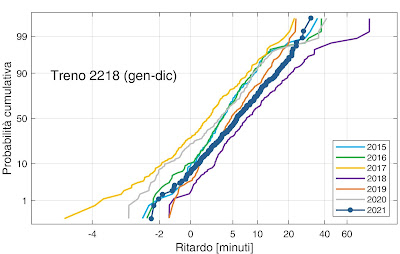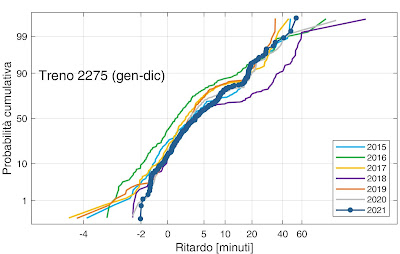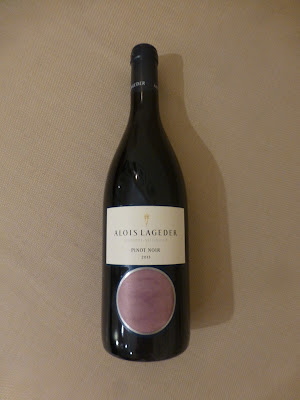di William S. Burroughs
Adelphi, Milano, 2010 (1a ed. italiana Sugar, 1964)
Traduzione di Franca Cavagnoli
Ma la noia U.S.A. non ha eguali. Non si vede, non si sa da dove viene. Prendi una di quelle sale da cocktail in fondo a una via: ogni isolato ha il suo bar, il suo mercato e negozio di alcolici. Tu entri e lei ti stende. Ma da dove viene? Non il barista, non i clienti, non la plastica color crema che ricopre gli sgabelli davanti al banco, non la fioca luce al neon. Nemmeno la TV.
E poi alla noia ci si assuefa, così come ci si assuefa a dosi sempre maggiori di cocaina. La roba cominciava a scarseggiare. Eccoci dunque in 'sto buco di città a farci di sciroppo per la tosse. Per poi vomitarlo e andare avanti, sempre avanti, con il freddo vento primaverile che soffiava nella discarica intorno ai nostri corpi in astinenza, sudati e tremanti, e il freddo che sempre senti quando nel corpo non circola più la roba... avanti attraverso il paesaggio sbucciato, armadilli morti in mezzo alla strada, avvoltoi sopra la palude e ceppi di cipresso. Motel con pareti di compensato, riscaldamento a gas, sottili coperte rosa.
Forse il modo migliore per iniziare a parlare di questo libro è descriverne la genesi. Tutto nasce da una fuga in Messico (pare per evitare
problemi a seguito di un traffico di droga) che l'autore compie con la moglie,
Joan Vollmer, da noi sconosciuta, ma in realtà personaggio importante della
beat generation. Il matrimonio non è propriamente tranquillo, tra alcool e droghe di cui entrambi fanno uso, e tendenze omosessuali di lui sempre più esplicite. Fatto sta che la sera del 6/9/51, ad un party, William le spara. La prima versione fornita è che i due stessero giocando a Guglielmo Tell, ma lui - ubriaco - sbaglia mira. Poi, cambia versione (te credo!!) e parla di un incidente. Fu condannato a due anni con la condizionale (la vicenda è raccontata ad esempio
qui).
Negli anni successivi WB vive tra Messico, Europa e la
Zona internazionale di Tangeri, dove, tra le allucinazioni della tossicodipendenza, scrive una serie di note che saranno poi "riordinate" e integrate, diventando
Pasto nudo.
Riassumere la trama è alquanto problematico, sia perché parliamo (anche) di allucinazioni e di deliri, sia perché secondo l'autore i diversi episodi raccontati possono essere letti in qualunque ordine; tuttavia, almeno la parte iniziale è abbastanza chiara: io partirei dall'ultimo (!) episodio,
hauser e o'brien (p. 212), due poliziotti che tentano di arrestare il protagonista (uno dei tanti), il quale riesce a fuggire (vi risparmio i dettagli per non rovinarvi la lettura). Ora torniamo all'inizio e leggiamo della fuga da NY verso il west e poi il Messico. I primi episodi sono quelli più lineari, e sono secondo me tra i migliori dal punto di vista dello stile della scrittura (ma bisogna almeno citare i due aneddoti alle pp. 135-140 in
uomini e donne qualsiasi).
Da qui in poi (e siamo solo a p. 32) la linearità della trama cede via via il passo alla potenza evocativa delle visioni e della paranoia, frammentandosi in episodi. Dal Messico si passa a Terralibera e poi a Interzona, un luogo traboccante di depravazione, dipendenza, esperimenti sadici e oscure trame politiche, dove si concentrano tutte le paure e i tabù dell'America (e non solo) di quegli anni (e non solo): omosessualità e promiscuità, relazioni interrazziali, violenza/tortura, sacrilegi, sinistri esperimenti "scientifici", il tutto inframmezzato da umorismo (nero) e tratti paradossali (la gara di degradazione, l'uomo vestito da pene ambulante, etc.).
In questi episodi si possono identificare alcuni temi ricorrenti: uno è certamente quello del controllo, esercitato tramite droga, soldi, sesso, su su fino alla burocrazia peggio-che-kafkiana del sistema totalitario di Annexia (p. 33), alle pratiche mediche di
ricondizionamento del dott. Benway e al
Congresso internazionale di psichiatria tecnologica (p. 112) dove si presenta l'uomo "deansiogenizzato", ovvero lobotomizzato. Più e oltre che una parodia critica dei sistemi totalitari e una visione paranoica dell'apparato statale (che prenderà piede tra i postmoderni), mi pare che l'ossessione di WB sia rivolta ai potenziali condizionamenti che la tecnologia può operare sul cervello (ricordiamo che in quegli anni si sviluppano i primi
mainframe computer): nella
Conferenza nazionale di Elettronica di Chicago (p. 164) un oratore dice (tra la felicità dei somari che oggi blaterano sui microchip sottocutanei):
Poco dopo la nascita un chirurgo potrebbe installare delle connessioni nel cervello. Si potrebbe inserire un radioricevitore in miniatura in modo che i trasmettitori controllati dallo Stato possano controllarlo a loro volta. [...] Come vedete il controllo non può mai essere un mezzo per perseguire un fine pratico... non può mai essere un mezzo per perseguire qualcosa che non sia un controllo maggiore... come la droga.
Accanto alla tecnologia ci sono ovviamente le leggi, le religioni (tutte ridicolizzate in diversi passaggi sacrilegi), le istituzioni, la burocrazia (assimilata al cancro). Da notare
en passant come la distopia tecnologica non vieti a Burroughs di intravedere qualcosa (p. 70):
Tra un po' le operazioni si faranno col telecomando su pazienti che non vedremo nemmeno... non faremo altro che premere bottoni, e, in tutt'altro ambito, assai poco politicamente corretto, la Islam Inc. (p. 152) dove
i martiri nazionalisti con le granate su per il culo si frammescolano ai convenuti e di colpo esplodono causando ingenti perdite di vite umane.
Un secondo tema è quello del
male, stigmatizzato dalle scene di violenza, mutilazione, linciaggio, malattia, putrefazione, ripetute alla noia (viene in mente De Sade). Se non vogliamo fermarci all'intenzione deliberata dell'autore di
urtare qualunque lettore (che pure esiste), se vogliamo trovare un significato allegorico (ma non tutti sono d'accordo), possiamo rifarci all'interpretazione data a questi passaggi sin dagli anni del processo per oscenità, che nasce da quanto dice l'autore riguardo al titolo (p. 239):
pasto NUDO - l'istante, raggelato, in cui si vede quello che c'è sulla punta della forchetta, ovvero il momento "della verità", in cui ci rendiamo conto di ciò che accade nel nostro mondo, di come funziona la nostra società. WB ripete ossessivamente queste scene ispirando disgusto e repulsione; repulsione per le scene, ma soprattutto per l'oscenità del mondo reale (alla quale, ad essere pignoli, lo stesso WB non era del tutto estraneo, visto che raccontava l'omicidio della moglie come "necessario" alla sua nascita come scrittore, ma su questo ci sarebbe molto da dire). Certo, leggere la "battuta" a p. 181 su quelli che danno fuoco ad un nero e non pagano la benzina è rivoltante, ma è così diverso da quello che è successo a
Emmett Till e tanti altri? E mettere la sedia elettrica in un museo della prigione o venderne modellini da costruire (accade veramente, ma mi rifiuto di indicare i link!) non è altrettanto schifoso, roba che non sarebbe venuta in mente nemmeno a Burroughs? Impossibile o quasi citare dei brani senza essere censurati; limitiamoci a questo, nel finale (p. 226):
I senatori balzano in piedi e invocano berciando la Pena di Morte con l'inflessibile autorità della fregola virale... morte per i tossicomani, morte per i froci (intendo i maniaci del sesso), morte per lo psicopatico che offende la carne intimidita [...] La manica a vento nera della morte ondeggia sulla terra, sentendo, annusando il crimine della vita separata, motori della carne raggelata dalla paura tremano sotto un'ampia curva di probabilità...
Le parti che dopo 50 anni appaiono meno problematiche sono quelle relative al sesso, escluso quando (spesso...) si colora di sadismo, e dove traspare un bel po' di misoginia. Vale però la pena di spendere due parole sulle aggiunte al testo: la lucida
Testimonianza di una malattia (scritta in occasione della prima edizione americana nel 1962) e la
Lettera di un supertossicomane da droghe pericolose (scritta negli anni di Tangeri), forse aggiunti per tentare di evitare la censura. Ci sono poi le
Riflessioni su una deposizione (1991), dove il significato del libro cambia ancora, dall'abuso di stupefacenti all'uso della guerra alla droga da parte dei governi per reprimere gli individui (p. 253):
Ora l'isteria antidroga si è diffusa in tutto il mondo e rappresenta ovunque una minaccia mortale per le libertà personali e per la corretta applicazione delle garanzie di legge.
Comunque la si voglia vedere, io leggerei queste parti
prima della parte testuale del libro, a mo' di introduzione. E, per finire, un commento al volo (ma ci sarebbe da parlarne a lungo) sulla versione cinematografica di David Cronenberg del 1991, che in realtà non è e non vuole essere un (impossibile) adattamento del libro, ma una riflessione sulla sua genesi, o sulla genesi dell'opera d'arte in generale, con elementi biografici di WB (l'omicidio della moglie, anche qui letto in chiave discutibile di affermazione artistica), parti tratte da altri lavori e lettere, e un notevole contributo originale del regista (ad es., tutta la parte sulla mutazione delle macchine da scrivere). Peccato solo per il pupazzone che rappresenta il Mugwump (il Moscibecco in questa traduzione italiana), che ha ben poco a che vedere con le allucinazioni del libro.