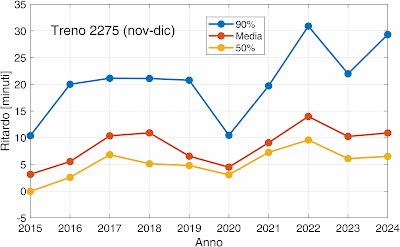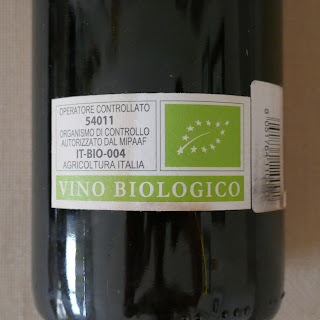Penguin Books, New York, 1986
I shopped for immediate needs and distant contingencies. I shopped for its own sake, looking and touching [...] I began to grow in value and self-regard. I filled myself out, found new aspects of myself, located a person I'd forgotten existed. Brightness settled around me. [...] I traded money for goods. The more money I spent, the less important it seemed. I was bigger than these sums. [...] These sums in fact came back to me in the form of existential credit.
L'interesse per questo libro nasce in primis... dal titolo! Il rumore (bianco, ma non solo) è uno degli argomenti fondamentali di ogni corso di Elettronica (ma non solo), e l'uso che ne avrebbe fatto DeLillo mi incuriosiva. Lo acquistai un dicembre di più di una ventina di anni fa, in una libreria di Washington vicina all'hotel dove si teneva la conferenza IEDM e... lo misi da parte dopo aver letto l'arcano Ratner's star. Ci sono libri da prendere alla lontana, da avvicinare con un po' di diffidenza, e poi da leggere con circospezione, cercando di non perdersi nel... rumore di fondo (il gioco di parole è fin troppo ovvio) per seguire una trama, scoprendo che alla fine trama e sottofondo, segnale e rumore, si compenetrano. Ma andiamo con ordine.
Il libro è diviso in tre parti. Nella prima (titolo evocativo Waves and radiation) si racconta la vita quotidiana della famiglia di Jack Gladney, un singolare "collega", chairman of the department of Hitler studies (p. 4), che insegna Advanced Nazism, a course of study designed to cultivate historical perspective, theoretical rigor and mature insight into the continuing mass appeal of fascist tyranny (p. 25; immagino avrebbe un certo successo anche dalle nostre parti...). Jack e famiglia, con i figli adolescenti che vengono da precedenti matrimoni e dimostrano un livello improbabile di maturità, conducono una vita "tipicamente americana", o meglio occidentale, regolata da televisione (siamo nell'era pre-Internet e pre-telefonini), radio, tabloid, e supermercato, dove (p. 19):
Most of all I like the packages themselves. You were right, Jack. This is the last avant-garde. Bold new forms. The power to shock. [...] I'm happy there. I read the TV listings, I read the ads in Ufologist Today. I want to immerse myself in American magic and dread.
Memorabile l'analogia (pp. 37-38) che Murray (un collega di Jack, appassionato di cultura popolare e che ricerca sempre interpretazioni profonde di ogni dettaglio, in bilico tra l'acume ed il ridicolo) pone tra il supermercato e l'interregno tra morte e rinascita nella cultura tibetana, un luogo sempre uguale dove ci si ricarica spiritualmente: Here we won't die, we shop. But the difference is less marked than you think. Nel supermercato si è subissati di rumori, annunci, colori, etichette da leggere (le uniche cose che ormai, secondo Murray, leggono i suoi colleghi all'università), waves and radiation, appunto. Le stesse cose, psychic data, sacred formulas, sono emanate dalla TV (pp. 50-51). Tutti i protagonisti sono immersi in questi codici, vero "rumore bianco" che agisce da costante controcanto alle vicende, e tentano a loro modo di decifrarli, da Jack che si interroga sul significato numerologico dell'ora a cui si è svegliato a Babette che legge gli oroscopi, da Denise che consulta i manuali di medicina fino alla polizia che si rivolge ad una sensitiva per ritrovare due dispersi (che saranno poi rinvenuti in un supermercato). La televisione ha anche un ruolo rassicurante, mostrando in continuazione disastri che attirano la nostra attenzione a patto che accadano altrove, reinforzando la nostra condizione di privilegiati (p. 66):
For most people there are only two places in the world. Where they live and the TV set. If a thing happens on television, we have every right to find it fascinating, whatever it is.
Questa condizione comincia a sgretolarsi nella seconda parte, costituita da un solo capitolo, quando il deragliamento di un treno rilascia una nube tossica che si avvicina alla città. Il buon Jack non riesce a crederci e continua a negare che ci possano essere conseguenze (p. 114):
These things happen to poor people who live in exposed areas. Society is set up in such a way that it's the poor and the uneducated who suffer the main impact of natural and man-made disasters. [...] I'm a college professor. Did you ever see a college professor rowing a boat down his own street in one of those TV floods?
Alla fine la famiglia deve evacuare, e durante il viaggio Jack scende dall'auto a fare il pieno di benzina, rimanendo esposto alla nube tossica. Nel campo profughi un anonimo operatore dietro ad un computer lo avvisa che la contaminazione è importante, ma che gli effetti non sono noti: potrebbe morire, forse a breve, forse tra molti anni o decenni. Dopo nove giorni, i Gladney possono rientrare a casa e la vita riprende il solito ritmo.
Siamo alla parte finale e la trama si movimenta. Jack scopre un contenitore di Dylar, una medicina sconosciuta che la moglie Babette assume di nascosto, e la fa analizzare nel laboratorio universitario. Saputo che si tratta di un neurofarmaco, confronta Babette, che confessa di essersi offerta volontaria per il test del Dylar, un farmaco sperimentale che dovrebbe inibire la paura della morte. Per via degli effetti collaterali, la sperimentazione su umani è vietata, ma Babette è terrorizzata dalla paura di morire e stipula un accordo privato con il responsabile del progetto. Per convincerlo a portare avanti il test, offre qualcosa di più della sua adesione, in una stanza d'hotel, per diversi mesi, finché il tutto non si interrompe perché il farmaco non ha effetto. Ora Jack vorrebbe provare il Dylar, vista la diagnosi che gli è stata fatta, ma le pillole rimanenti sono state distrutte e Babette non vuole rivelare il nome del contatto, che tuttavia Jack recupera fortuitamente. Stretto tra la gelosia e la paura, lo incontra per ucciderlo, gli spara, ma alla fine lo salverà portandolo in un ospedale d'emergenza gestito da suore.
Nella seconda e terza parte appare evidente come la morte e la paura di morire siano il principale tema del libro: la morte fa capolino già dalle prime pagine, quando i ricchi borghesi portano i figli all'università e Babette si chiede cosa sia la morte a quel livello di reddito, compare costantemente nel testo, ed i due discutono su chi morirà prima (cap. 20). Come gli rivela Murray (cap. 37), Jack ha proiettato sulla figura di Hitler la sua paura di morire, perché (p. 287)
helpless and fearful people are drawn to magical figures, mythic figures, epic men who intimidate and darkly loom [...] The overwhelming horror would leave no room for your own death
ma alla fine senza successo: la realtà (o almeno, la realtà che viene raccontata dalla tecnologia medica) sbriciola queste credenze assieme all'immagine che il professore si era costruito di sé, con la toga, gli occhiali scuri e le iniziali finte del nome (emblematico di ciò è il discorso con il tecnico al campo profughi, dove Jack vorrebbe indossare il suo abito accademico). Non potendo/volendo votarsi alla tecnologia o alla fede né possedendo la spavalderia di Orest (che entra in una gabbia di serpenti per sfida), si affida ad una suggestione del solito Murray secondo cui la violenza è una forma di rinascita (p. 290) e uccidere è un modo per controllare la propria morte, evocando una "sostituzione" di ruolo tra assassino e vittima. Ma anche questo piano fallisce (anzi, si ribalta, perché proprio la ferita lo spinge a salvare Mink), e nemmeno la suora del convento, che professa di non credere nell'ultraterreno ma di recitare una parte affinché il mondo possa consolarsi all'idea della fede, fornisce una soluzione. Non resta che tornare alla vita di prima e accettarla.
Tra i molti altri temi che scorrono tra le pagine val la pena di citare il ruolo della tecnologia: da un lato, è una minaccia oscura che raccoglie dati e sa tutto su di noi (la prima edizione del libro è del 1985, molto in anticipo sulle recenti preoccupazioni al riguardo), senza però fornire informazioni utili, come il responso nel campo profughi o gli esiti degli esami e dei colloqui con i medici, iniziati alla tecnologia e sempre assurdamente ambigui. Ma essa ha anche una funzione rassicurante di "integrazione", come quando Jack si reca ad uno sportello Bancomat e inserisce la sua carta ed i codici, ricevendo le informazioni desiderate (p. 46):
Waves of relief and gratitude flowed over me. The system had blessed my life. I felt its support and approval. The system hardware, the mainframe sitting in a locked room in some distant city. What a pleasing interaction. I seemed that something of deep personal value, but not money, not that at all, had been authenticated and confirmed. [...] The system was invisible, which made it all the more impressive, all the more disquieting to deal with. But we were in accord, at least for now. The networks, the circuits, the streams, the harmonies.
Altri esempi ovvi sono la nube tossica e la modifica del paesaggio e dei colori, contrapposta allo stesso Dylar, technology with a human face (p. 211), che, sebbene non funzionante oggi, potrebbe esserlo un domani (p. 308):
Dylar failed, reluctantly. But it will definitely come. Maybe now, maybe never.
Bisogna poi notare come DeLillo già si fosse accorto che la pervasività della tecnologia non avrebbe scalfito la fede nell'irrazionale, perché proprio la complessità della tecnologia la rende assimilabile al magico (si veda l'argomentazione di Heinrich alle pp. 146-7). E quindi, ecco i predicatori, le "notizie" sulle prove di vita ultraterrena, di reincarnazione, UFO, gli oroscopi, le argomentazioni formalmente solide, ma in realtà risibili dello stesso Heinrich che si rifiuta di decidere se stia o meno piovendo (pp. 22-24) e che sciorina teorie complottiste (cap. 23) che oggigiorno gli varrebbero un incarico politico. Heinrich for President!
Un ultimo cenno è anche dovuto all'adattamento cinematografico di Noah Baumbach del 2022, non del tutto riuscito. Se dal punto di vista visuale il film rende molto bene la frenesia dello shopping e la catastrofe della nube, mi pare che manchi un collegamento convincente, per chi non ha letto il libro, tra gli eventi narrati ed il tema fondamentale della paura della morte, che pur viene ribadito numerose volte.
P.S. un gruppo musicale ha mutuato il nome da quello (fittizio) della sostanza tossica, Nyodene D.